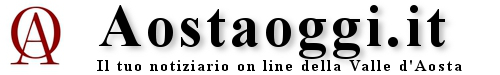Caro essere umano che ti approcci a me,
non chiedermi “Come stai?” se, poi, non t’interessa ascoltare la risposta che vorrei darti veramente. Hai mai fatto caso che le persone, quando s’incontrano tra loro per la strada o comunque in un luogo pubblico, dicono sempre le stesse cose? “Come stai?” “Bene. E tu?”.
Si tratta di un copione, ogni volta identico a se stesso. Sono i cosiddetti convenevoli. Bisogna scambiarseli in società: è una consuetudine. Un po’ come i preliminari prima del sesso. Con l’unica differenza che, nel secondo caso, si esprime realmente chi si è. Cosa si vuole. Cosa non si vuole. O, almeno, così dovrebbe essere.
Ma, per tornare al nostro discorso – caro essere umano che ti approcci a me – chiedere “Come stai?” non è un’azione da poco. Non è una domanda da fare alla leggera. Come ci sono tante altre frasi che non si possono pronunciare alla leggera. “Ti voglio bene”, per esempio.
Sono perfettamente cosciente che nel mondo altamente performante di oggi non c’è alcuno spazio per la verità. Specialmente se si tratta di una verità amara. E anche un po’ scomoda. Perché se io, alla domanda “Come stai?” rispondessi “Sto male”, ti allontaneresti immediatamente da me.
Vedi – caro essere umano che ti approcci a me – non è il male fisico che ti spaventa. Lo so. Il male che ti terrorizza e ti fa scappare via è quello psicologico. Ne sono consapevole, perché è il mio stesso tipo di reazione.
Ti sembra strano, forse? A me no. La mia psicoterapeuta mi ha detto, più di una volta, che io per prima stigmatizzo la malattia mentale. E, se mi faccio un vero esame di coscienza, mi rendo conto che ha ragione.
In questo momento, non potrei essere più sincera di come sono. Credimi. Quasi ogni giorno, le cronache sui giornali raccontano di uno dei delitti più atroci che si possa commettere: l’omicidio. Spesso, la strategia difensiva degli avvocati che prendono in carico degli assassini consiste nel dichiarare l’infermità mentale del proprio assistito. Come se la risposta a tutti i mali del mondo fosse questa.
“Ha ucciso. Quindi non sta bene”. È questo l’assioma. È la strada più comoda, la più facile, la più praticabile e praticata. Forse, io ho deciso di scrivere di salute mentale per sfatare questo falso mito. Chi soffre di malattie mentali non fa automaticamente del male fisico agli altri. La maggior parte delle volte, lo fa a se stesso.
Il dolore che ognuno di noi può provare non è solo quello fisico, ma soprattutto quello psicologico. A provocarlo non sono delle percosse, ma delle parole e dei gesti – più o meno volontari – che c’infliggiamo a vicenda.
Sai, caro essere umano che ti approcci a me, sono stata invitata a partecipare alla Giornata Mondiale della Salute Mentale – di cui ti racconterò il mese prossimo – per parlare di quest’ultima e della sua rappresentazione narrativa. Capisci il paradosso? Io ne scrivo apertamente, però temo per la sua labilità.
Ma mi rendo conto, ogni giorno di più, che me ne spavento perché ho grosse difficoltà nell’affrontarla. Sia quella mia che quella degli altri. Specialmente quando gli altri negano di avere un problema psicologico e mi ricordano che la persona a cui è stata diagnosticata una malattia mentale sono io.
Ciò nonostante, non credo che lo facciano per cattiveria. Non tutti, almeno. Lo fanno per paura. Paura di sentirsi additati ed etichettati in un certo modo. Paura di essere giudicati. Paura di… ciò che si è.
Ognuno di noi, infatti, ha un’interiorità difficile da conoscere fino in fondo. E forse, anzi probabilmente, dovrebbe chiedere “Come stai?” a se stesso. E non prima che agli altri, ma dovrebbe chiederlo a se stesso… e basta. Perché la risposta è difficile da dare, da darsi. Per farlo, potrebbe non essere sufficiente una vita intera.
Barbara Giangravè
(